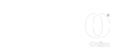Recentemente ho curato l’edizione italiana in ebook di un breve saggio intitolato Razionalità digitale. La fine dell’agire comunicativo del filosofo coreano-tedesco Byung-Chul Han. Il testo, accompagnato da un saggio introduttivo di Ubaldo Villani-Lubelli e dalla postfazione della professoressa Federica Giardini, si confronta con un macro-tema interessante e molto rilevante per la comprensione delle nostre società contemporanee. Si tratta dell’avvento di internet e di come questo avvento modifichi e potrebbe modificare le nostre vite e in particolare di quali sono gli effetti sulle nostre organizzazioni politiche.
La fine dell’agire comunicativo
La questione non è legata ad una semplice e plausibile informatizzazione dell’apparato statale, non si richiude semplicemente, come a volte si pensa, su una mera questione di tecnologia o di avanzamento tecnologico. L’autore del testo anzi si concentra sui mutamenti quasi “antropologici” che comporta l’avvento di una interconnessione permanente tra gli individui. Il sottotitolo della pubblicazione “la fine dell’agire comunicativo” già esplica la prospettiva che ci si apre davanti: un cambiamento radicale di come la convivenza si strutturi e soprattutto di come vada pensata. Byung-Chul Han è provocatorio e lo dice chiaramente: bisogna abbandonare il paradigma del passato per inventarsene uno nuovo.
Spazio pubblico e spazio privato
Una cosa più semplice a dirsi che a farsi, perché se in un primo momento tutti si potrebbero dire d’accordo, bisogna anche comprendere quali siano le conseguenze effettive di questo evento. Cos’era “l’agire comunicativo”? Per chi non lo sapesse si tratta di una teoria del filosofo Juergen Habermas pressoché accettata nel mainstream filosofico e sociologico almeno fino a qualche tempo fa. Semplificando molto, l’idea di fondo, è che le società moderne si sono strutturate secondo la distinzione di uno spazio privato e uno spazio pubblico. Lo spazio pubblico era una sorta di arena in cui le opinioni sviluppate nel privato si confrontavano per risolvere i problemi comuni e secondo una razionalità (astratta) potevano poi portare al raggiungimento di una soluzione o di un compromesso. Il dialogo sarebbe quindi una sorta di duello disarmato a colpi di retorica e dialettica in cui la posizione più razionale trionferebbe.
Cos’è razionale
Sulla carta è molto bello. Di fatto è il trionfo delle ideologie liberali (e anche liberiste: la produzione razionalmente migliore non è quella che dovrebbe giustamente conquistare una posizione di dominio sul mercato esattamente come l’opinione politica più razionale dovrebbe conquistarsi un posto naturalmente privilegiato?). Il problema è che “cosa sia razionale” lo decidono spesso chi già sta in una posizione di dominio. Molto belle, le nostre società, non sono mai state nemmeno in pieno dominio di questo paradigma.
L’avanzamento tecnologico
Dicevamo: cosa significa cambiare aria? Non vuol dire rifare da capo le stesse cose, pensare attraverso la l’avanzamento tecnologico (in questo caso la dimensione della rete) di poter finalmente realizzare un paradigma del passato. Significa anzi abbandonare certe categorie. Abbandonare il paradigma moderno – così l’autore – significa anche abbandonare una serie di strumenti e termini che lo hanno caratterizzato: dialogo, soggetti, spazio pubblico. Tutto questo va buttato all’aria. Già ora ci rendiamo conto che quanto poteva essere accolto con entusiasmo sull’onda della grande passione per il cambiamento potrebbe non essere così piacevole o semplice come si credeva.
Isolati, a-comunicativi, individuali
Byung-Chul Han non si ferma al suscitare in noi dei dubbi. Dà qualche suggerimento più preciso. Bisogna essere capaci di creare una democrazia fondata sul nuovo modo di vivere interconnessi: isolati, a-comunicativi, individuali. Praticamente un incubo! O, e questa è la provocazione maggiore, non è che l’incubo è tale solo all’interno del paradigma del passato?
Internet e società
Il discorso ha indubbiamente i suoi limiti, in parte riconosciuti dall’autore stesso. L’approdo all’incubo-non-incubo di cui parla Byung-Chul Han tralascia una serie di riflessioni filosofiche e sociologiche, così come una effettiva attenzione alle pratiche politiche che materialmente hanno strutturato la società (anche quella moderna, al di là della lettura fattane attraverso la teoria dell’agire comunicativo). Nonostante ciò, la questione è importante e il testo ha il pregio di essere chiaro: se la società sta cambiando e se vogliamo cambiarla in meglio, ha senso attraverso internet, voler continuare a fare quello che si voleva fare prima?