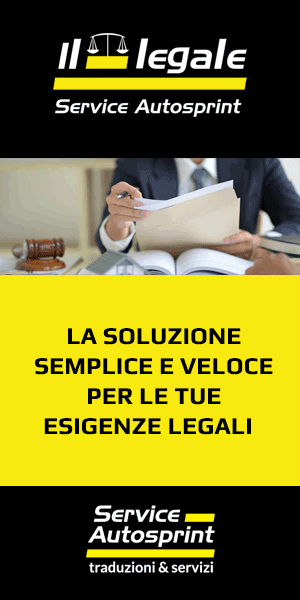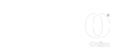“Non sono nate per generare profitti personali. L’obiettivo principale di una Cer è fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri, soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile”. Giancarlo Beltramo, esperto del settore energetico, ha aperto con queste parola la sua relazione alla conviviale del Rotary club Crema al Ridottino. Come spiegato dal presidente del sodalizio, Antonio Grassi, l’occasione per “illustrare con chiarezza una materia complessa”. Per i cittadini il vantaggio concreto “è l’incentivo a fondo perduto del 40 per cento finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici e riservato agli abitanti dei comuni sotto i 5.000 abitanti. Chi aderisce dovrà rimanere nella comunità per almeno cinque anni e con una tariffa incentivante leggermente ridotta”.
Comunità e legame col territorio
Insomma, con le Cer “non si fanno soldi con piccoli risparmi in bolletta. Facendo due conti, il guadagno annuale si aggira attorno a una cena al ristorante”. Il concetto che sottende il tema, rivoluzionario, è chiaro: “Se l’obiettivo fosse il profitto, non si parlerebbe di comunità”. Il vero valore delle Cer, ha ribadito Beltramo, consiste nella realizzazione di “un nuovo modello energetico: più sostenibile, più partecipato, capace di ridurre le emissioni di gas serra e limitare la dispersione di energia”. I vantaggi non si fermano qui: “le Cer offrono un’occasione per rafforzare il legame tra i cittadini e il territorio in cui vivono o lavorano”.
La questione giuridica
Ormai è trascorso un lasso di tempo sufficiente e la situazione si è chiarita: “per le pubbliche amministrazioni, le forme giuridiche più adeguate sono l’associazione riconosciuta e la fondazione di partecipazione. Partiamo dalla prima: “l’associazione riconosciuta è un’organizzazione collettiva senza scopo di lucro, che può svolgere attività economiche accessorie ma non può distribuire utili ai propri membri. Può essere iscritta al Terzo settore, ha una netta autonomia patrimoniale rispetto agli associati. Il patrimonio minimo richiesto è di 15.000 euro e lo statuto deve definire in modo dettagliato l’organizzazione e le regole di amministrazione”.
Il futuro
Nel secondo caso, “la Fondazione di partecipazione è una forma giuridica ibrida. Con il coinvolgimento dei partecipanti e il conferimento di beni unisce elementi personali e patrimoniali. Garantisce una buona autonomia e si presta a una gestione semplificata, soprattutto in caso di partecipazione prevalente. Richiede un patrimonio minimo di 30.000 euro e la costituzione deve avvenire tramite atto pubblico”. Quale futuro ci attende? “Il successo delle Cer dipenderà dalla nostra capacità di cooperare e di mettere al centro il bene comune, più che il vantaggio personale”.