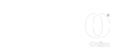Valeva la pena di aspettare 16 anni per ascoltare il nuovo disco dei Cure? Si. Se siete tra quelli che leggono le prime righe di una recensione potete tranquillamente chiudere qua e appoggiare la puntina sui solchi di “Songs of a lost world” (perché mi auguro che il nuovo disco di Robert Smith e soci lo ascolterete in vinile) e godervi questo monolite nero di 50 minuti che vi proietterà, come il titolo promette, in un mondo perduto.
Se invece volete proseguire nella lettura cercherò di dirvi perché secondo me questi agognati 50 minuti valevano tutta l’infinita attesa. Partiamo da due date. Il 14 febbraio del 2008 sbarcava anche in Italia Facebook. Il 27 ottobre del 2008 usciva “4.13 dream”, l’ultimo deludentissimo disco della band di Crawley. Basterebbero queste date per fare capire che dall’ultima volta che avevamo potuto ascoltare musica nuova di casa Cure il mondo è radicalmente cambiato. Senza volere tirare in ballo troppe mutazioni sociologiche basti dire che 16 anni fa era impensabile la fruizione musicale a cui oggi siamo ampiamente abituati: frattaglie di musica a brandelli di 30 secondi per musicare reel social, magari pure accelerata per comprimere più cose possibili in un battito di ciglia. Noi ascoltavamo suite da 25 minuti per cercare l’infinito. I ragazzi di oggi accelerano Lady Gaga per i balletti social.
Oggi una canzone deve durare meno di 3 minuti, arrivare al sodo del ritornello in 20 secondi, catturare al primo ascolto, diventare virale. Tutte cose di cui Robert Smith se ne frega, e se ne è ampiamente fregato per comporre gli 8 pezzi di questo nuovo disco. Il pezzo di apertura, Alone, che è stato anche il singolo di lancio, ha una introduzione strumentale di 3 minuti e le prime parole che Smith canta sono un urlo lancinante che recita: “This is the end of every song that we sing”. Un manifesto. L’ultima canzone del lotto, Endsong, dura 10 minuti e 23 secondi e il cantato arriva dopo 6 minuti di feedback chitarristici, montagne di tastiere, loop marziali di batteria. Sia chiaro non voglio farvi una recensione track by track, quelle le troverete sui siti specializzati di musica.
Voglio solo dirvi che a 53 anni in questi mesi di attesa, da quando è stata annunciata l’uscita del disco, e in questi primi emozionati ascolti mi sono sentito come il sedicenne in spleen che si crogiolava nella cupezza di “Faith” o nelle infinite cupe melodie di “Disintegration”. E non pensavo di potermi permettere ancora simili emozioni. Quindi se siete arrivati fin qui e non vi siete fermati dopo il “si vale la pena” della prima riga vi auguro di provare queste stesse emozioni ascoltando questa musica da un mondo perduto. Un mondo che non avremmo mai creduto di ritrovare. Perché a 65 anni Robert Smith è ancora quel ragazzo immaginario che nel 1979 scrisse un pezzo immortale come 10.15 Saturday Night ispirandosi al suono della goccia del lavandino della cucina che drip, drip, drip… perdeva.
Perché a 65 anni Robert Smith è ancora quel ragazzo immaginario che nel 1979 scrisse un pezzo immortale come 10.15 Saturday Night ispirandosi al suono della goccia del lavandino della cucina che drip, drip, drip… perdeva.
[di Emanuele Mandelli]
Hello image sing me a line from your favorite song. Quando penso ai Cure necessariamente penso alla prima strofa di M. Peraltro l’iniziale del mio nome, in un gioco di coincidenze, in un gioco di correlativi oggettivi che ciclicamente tornano. Era febbraio, e riascoltavo in macchina The hungry ghost pensando a quanti anni fossero passati dall’uscita di quella canzone. Oggi faccio quasi fatica a parlare di un nuovo album dei The Cure, “Songs of a lost world”. Perché ora quell’orologio ha smesso di scorrere. Un disco che non necessariamente si attendeva da 16 anni, ma che in fondo era diventata quasi una leggenda popolare di cui discorrere mentre si degustava un dolce con gli amici (avrò l’animo dark ma sugar sloppy slut rimango, per parafrasare Rick Owens). Un disco che ho talmente tanto atteso e che giustamente mi son ricordato essere uscito solo ieri nel tardo pomeriggio.
Quindi eccoci qua, e ve lo dico senza tanti fronzoli: a me il disco è piaciuto. I Cure sono uno dei miei gruppi preferiti, li metterei nella triade di artisti che hanno plasmato il mio orizzonte culturale, ma non arrivo a livelli di idolatria. Ci provo quindi a essere razionale. E se fallirò, la prossima volta mi impegnerò a fallire meglio.
Sedici anni sono davvero tanti, e forse “peggio” di loro ci sono stati solo i My Bloody Valentine, che dal loro capolavoro assoluto Loveless a MBV hanno fatto passare più di 20 anni. In quel caso MBV li ha riconfermati la band migliore al mondo nel far quel che fanno. Vale lo stesso per i Cure? Onestamente non lo so. L’estetica e i suoni a cui la band di Robert Smith rimandano ha una nicchia culturale e stilemi ben consolidati, a volte fossilizzati nel tempo e non invecchiati sempre bene, forse per colpa dello stesso pubblico, fra i più reazionari che esistano (ed è paradossale, parlando di controcultura). Il rischio di diventare la copia di se stessi era quindi altissimo, e per fortuna così non è stato. Abbandonate le sonorità dei loro ultimi 2 album (The Cure e 4:13 Dream) in cui stancamente cercavano di rinnovare il loro sound , il suono di questo ultimo disco porta a un ideale collegamento con la loro Trilogia più celebre. Il Tassello mancante che chiude, per ora, il discorso iniziato con Pornography (1982), proseguito con Disintegration (1989) e precedentemente chiuso con Bloodflowers (2000).
Ora, questo nuovo disco non si avvicina, per ora, alla meraviglia dei suoi predecessori, ma non ha importanza. E’ probabilmente il meglio che possiamo avere dai Cure in studio nel 2024 e va bene così. Non sono diventati come temevo la copia di loro stessi, e questa è la cosa più importante. Il suono di questo disco riprende la pioggia di tastiere a la Disintegration portandolo nel mood da lirismo malinconico di Bloodflowers (che ai più farà cagare, ma per me rimane il loro secondo album più bello dopo Disintegration che, come dissero i fanciulli di South Park, is the best album ever).
This is the end of every song that we sing. SOALW in realtà contiene canzoni che sono nuove solo in parte, in quanto 6 delle 8 tracce erano già state presentate nel loro ultimo tour mondiale del 2022. L’abum si articola in 2 canzoni di straordinaria importanza all’inizio e alla fine, ossia Alone e Endsong. Nel resto del disco troviamo altre canzoni dalla struggente malinconia come And nothing is forever, A fragile thing (molto più bella che nelle sue versioni dal vivo) supportate dalle meravigliose tastiere di O’Donnel. Ho personalmente apprezzato meno i due inediti veri, ossia Warsong (anche se funge da buon traghetto tra la prima e la seconda parte del disco) e Drone:Nodrone. Sicuramente è un disco organico, che va vissuto e ascoltato nella sua interezza. La sua forza di insieme è verosimilmente maggiore di quella dei suoi brani presi singolarmente.
A livello sonoro, quello che per me non funziona è ciò che critico loro da almeno un decennio, ossia il chitarrista Reeve Gabriels. Lo trovo totalmente fuori contesto nel loro sound. E’ un chitarrista, per quanto estremamente talentuoso, di estrazione maggiormente rock, e in suono semplice quale quello dei Cure risulta essere inutilmente protagonista, rovinando queste canzoni ( e i loro classici durante i live).
And I'm outside in the dark staring at the blood red moon. Ci si trova quindi alla fine di Endsong, sotto quella luna rossa sangue di cui canta Robert, domandandosi davvero come si sia giunti li, come siano passati 16 anni e se davvero sia la fine. Di sicuro, per quanto imperfetto, SOALW potrà risultare il degno epitaffio di una band che incide con il bisturi le nostre anime da quasi 50 anni.
[di Matteo Raise]











 Perché a 65 anni Robert Smith è ancora quel ragazzo immaginario che nel 1979 scrisse un pezzo immortale come 10.15 Saturday Night ispirandosi al suono della goccia del lavandino della cucina che drip, drip, drip… perdeva.
Perché a 65 anni Robert Smith è ancora quel ragazzo immaginario che nel 1979 scrisse un pezzo immortale come 10.15 Saturday Night ispirandosi al suono della goccia del lavandino della cucina che drip, drip, drip… perdeva.