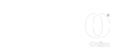La piazza, la cattedrale del Duomo e il palazzo del comune di Crema, così come li conosciamo oggi, risalgono a tempi lontanissimi. Iniziò tutto nel 1525, dopo una distruzione. Ad approfondire questo periodo storico cremasco – e non solo – ci ha pensato Simone Caldano con la pubblicazione del volume Crema tra Medioevo e Rinascimento. Il duomo e la sua piazza: fonti scritte, architettura, tessuto urbano. Ieri, sabato 15 marzo, in una sala Ricevimenti gremita di persone, il volume è stato presentato dai relatori Guido Cariboni, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Luisa Giordano, dell’Università degli Studi di Pavia. L’appuntamento rientra nella rassegna A immagine del leone. Storia, istituzioni e architetture del potere a Crema in età veneziana, organizzata dall’assessorato alla cultura, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo (dipartimento di giurisprudenza), la Pro Loco cittadina, l’Uni-Crema e la Società Storica Cremasca.
Una restituzione alla comunità
Il presidente della Pro Loco, Vincenzo Cappelli, ha introdotto l’incontro al pubblico. Nel suo discorso ha sottolineato come questa presentazione sia “un momento significato per la vita culturale della città. Oggi presentiamo una pubblicazione che restituisce alla comunità e al territorio cremasco un prezioso lavoro di ricerca intrapreso da Simone Caldano. Il libro, fortemente voluto dalla Pro Loco per la celebrazione del quinto centenario della costruzione del palazzo comunale, offre una lettura a tutto campo del cuore pulsante di Crema: introduce alla conoscenza approfondita della piazza Duomo e dei suoi monumenti”.
L’unione di due materie
Lo storico Cariboni ha voluto fin da subito evidenziare il carattere del volume: “è una pubblicazione non solo di storia dell’architettura, ma anche di storia. Il rapporto tra storia e storia dell’arte non è sempre stato improntato a collaborazioni e interazioni”. Partendo da questa premessa, viene messo in mostra un ulteriore passo avanti fatto dall’autore: “la ricerca storica e la ricerca dell’arte si completano l’un l’altra, in alcuni capitoli le due materie sembrano un tutt’uno. Le fonti storiche servono per ricostruire un tessuto e le opere d’arte servono come fonti per la ricerca storica. Simone Caldano ha mestiere, sia per la parte storica medievale che per la parte storica dell’architettura. L’autore intreccia fonti narrative e documentarie, arrivando ad una conclusione innovativa: la distruzione di Crema fu tutt’altro che totale, la città non venne rasa al suolo, perché strutture difensive e luoghi di culto riuscirono a sopravvivere. Infine, l’intreccio tra la documentazione scritta e le traccie materiali sopravvissute permetto la ricostruzione del nucleo urbano nel suo complesso”.
La filologia sul monumento
Secondo la storica dell’arte Giordano, l’approccio di Caldano è stato quello di “unire le due discipline per ottenere un ottimo prodotto, vi è compenetrazione tra ricerca storica e storico artistica. Di libri così approfonditi ce ne sono ben pochi in circolo. Il volume si muove su molteplici piani: nell’ambito specifico della storia dell’arte, c’è uno studio approfondito accompagnato da corollari, sviscerati in maniera minuziosa come se fossero loro i campi della ricerca. La filologia sul monumento con Caldano è diventata corpo, materia concreta per la ricerca storico artistica. Crema è una “quasi città”, si esprime con un Duomo che è quasi alla pari di quelli che si trovano nella città. Però, nel suo piccolo, si afferma una facciata a vento altissima, slanciatissima”.
Il volume
Crema tra Medioevo e Rinascimento. Il duomo e la sua piazza: fonti scritte, architettura, tessuto urbano prende in esame il fulcro di una vivace ‘quasi-città’ e le sue trasformazioni tra l’XI e il XVI secolo. In questo lungo arco cronologico Crema attraversò una vicenda storica complessa: attestata per la prima volta nel 1074, per molto tempo fu legata strettamente alla città di Milano, nel 1335 entrò nella dominazione viscontea e nel 1449 si verificò la dedizione alla Repubblica di Venezia. Molti snodi di questa vicenda non trovano un quadro di riferimento di carattere generale. Dall’incrocio tra le fonti scritte, le testimonianze architettoniche e la progressiva definizione del tessuto urbano esce l’immagine di un comune non libero e di un capitolo canonicale privo di dignità pievana, che però seppero esprimere le potenzialità necessarie all’avanzamento dell’ambizioso cantiere tardomedievale del Duomo, in grado di rivaleggiare con le cattedrali del tempo. L’indagine sulla piazza rinascimentale si basa su una ricchissima quantità di fonti documentarie, finora mai prese in considerazione. Con la dedizione alla Serenissima fu aperto il cantiere di un palazzo comunale che poteva fare affidamento sulla prosperità della comunità cremasca, mentre fu diametralmente opposto il faticoso processo che a partire dal 1525 portò alla costruzione del palazzo che tuttora si vede. La ricerca fa tesoro delle acquisizioni più aggiornate, individuando il transito da un medioevo lombardo a un rinascimento veneto negli orizzonti culturali dei committenti, degli architetti e delle maestranze, di pari passo con le vicende istituzionali.