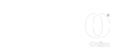La serata del Caffè filosofico di lunedì 10 febbraio presso il Gallery ha ricondotto all’attenzione della città l’opera di un talentuoso aristocratico, nato e vissuto fra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, poco lontano dalla sede del Caffè. Percorrendo via Mazzini verso piazza Garibaldi, si incontra il palazzo Vailati, casa natale di Giovanni, l’unico filosofo di cui Crema possa fregiarsi. Solitamente definito filosofo-matematico, Giovanni Vailati, tralasciando gli studi a Lodi e a Torino e alcuni viaggi per motivi di studio o di lavoro, vive fra Crema e Offanengo, nell’abitazione di campagna dove la famiglia, secondo le abitudini delle casate nobiliari, trascorreva l’estate. Ma il suo pensiero, corroborato dalla conoscenza di lingue antiche e moderne e arricchito da molteplici interessi artistici e scientifici, si forma a stretto contatto con intellettuali italiani, europei e d’Oltreoceano. Il confronto era tenuto vivo da lettere, scambi di idee e osservazioni critiche, sempre pacatamente argomentate e tese ad innalzare il livello della cultura italiana. Vailati non scrisse il classico capolavoro che passa alla storia come sintesi dell’Autore. Ma produsse saggi e articoli che dopo la sua morte vennero riuniti nel ponderoso tomo intitolato Scritti, a cura di M. Calderoni, U. Ricci, G. Vacca, Firenze-Leipzig, Seeber-Barth 1911, consultabile presso la Biblioteca di via Civerchi.
Gian Falco e Giuliano il Sofista: chi erano costoro?
L’argomento della serata è Alla ricerca di “alleati” e “compagni d’arme”. Il filosofo cremasco Giovanni Vailati e il “Leonardo”. Relatore Luca Natali, assegnista di ricerca e professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano, nonché, last but not least, ex alunno del professor Franco Gallo. Natali, che nel 2024 ha curato per Bibliopolis il testo Scritti dal “Leonardo”, ricostruisce con scrupolo filologico l’atmosfera culturale degli anni 1903-1907, quando uscirono i 25 numeri della rivista “Leonardo”, gli stessi – ad eccezione del 1907 – in cui si colloca la collaborazione del filosofo cremasco. Vailati, allora sulla quarantina, si era imbattuto in due toscani scalmanati e pieni di entusiasmo, con un’infarinatura di filosofia e tanta voglia di “svecchiare” o, come si direbbe ora, “rottamare” la cultura accademica. Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini, ancor prima di incontrare Vailati, erano i classici amici che litigano fra loro per capire che cosa vogliono nella vita. Come ebbe a scrivere Antonio Santucci nel libro Il pragmatismo in Italia (1963), essi condividevano “la nausea del banale e dell’ordinario, il disprezzo per le buone maniere, l’amore dell’eccezionale”, e gli obiettivi polemici: positivismo e democrazia. E lo facevano con accenti da Sturm und Drang e sfrontatezza giovanile. Quando, nel gennaio 1903, intrapresero l’avventura del “Leonardo”, i due amici si firmarono con un nom de plume. Scelsero Gian Falco (Papini) e Giuliano il Sofista (Prezzolini). Falco, suppongo, per velocità, agilità e acutezza. Giuliano il Sofista, secondo quanto narrato da Prezzolini, in omaggio a quel Giuliano l’Apostata che aveva osato rifiutare il cristianesimo consacrato da Costantino come religione ufficiale dell’Impero per riportare alla luce la tradizione del paganesimo. Ma anche per simpatia con Giuliano Sorel (non George, ma Julien, protagonista di Il rosso e il nero di Stendhal), da cui aveva “preso lezioni di volontà e di energia”. I Sofisti, poi, “sempre condannati dalla filosofia ufficiale e professorale” gli pareva dovessero essere “persone simpatiche”.
Amici diversi
A questo punto ci si domanda che cosa potessero avere in comune quei monellacci dallo stile roboante e retorico con il pacato, educatissimo nobile di provincia, in corrispondenza epistolare con eminenti nomi del panorama filosofico-scientifico internazionale. Per misurare la distanza fra quelle personalità basti un esempio: di fronte allo sfascio della scuola italiana, nel 1905 Vailati, su invito di Gaetano Salvemini, siede nella Commissione Reale per la riforma della scuola media. Nel 1914, invece, Papini proporrà il pamphlet Chiudiamo le scuole. Non si tratta peraltro di una mera questione di carattere: mentre Vailati era un liberale giolittiano, i giovani toscani erano anarcoidi individualisti che partivano lancia in resta contro capitalismo, borghesia, socialismo. Ma anche lo stile di scrittura di Giovanni Vailati è ben lontano da quello di chi sentenzia: “l’unico testo di sincerità nelle scuole è la parete delle latrine”. Chi legge gli scritti di Vailati rimane piacevolmente sorpreso nello scoprire che, pur essendo magari digiuno di preparazione scientifica, riesce ad appassionarsi e comprendere ciò che sta leggendo. I temi di storia delle scienze, metodologia scientifica, logica e matematica vengono infatti presentati in una prosa piana, pur nella complessità degli argomenti e nel periodare tecnico e precisissimo. Ciò dà ragione fra l’altro a Vailati che, rinunciando alla carriera di docente universitario, preferì insegnare matematica negli Istituti tecnici, dove si guadagnò l’affetto degli studenti grazie alla propria efficacia comunicativa. Quella piacevole sensazione di capire ciò che si legge è paragonabile a quella dell’inesperto di temi giuridici quando affronta libri di Norberto Bobbio.
Scienziati e maghi
Il professor Natali lo dice con chiarezza: Vailati sperava di utilizzare il “Leonardo” per lanciare in Italia il pragmatismo, o addirittura trasformare la rivista nell’organo del pragmatismo. Più precisamente, egli simpatizzava per il pragmatismo logico alla Charles Peirce, e propendeva per un previsionismo consistente nell’ipotizzare quali fenomeni potrebbero verificarsi, qualora si ponessero certe condizioni. Ciò vale anche per le definizioni di concetti fisici. Così, definire le proprietà possedute da un corpo, ad esempio il peso, equivale a rappresentarsi “dei fatti che avverranno, o che avverrebbero, se tale corpo venisse posto in tali o tali altre circostanze”. Nel caso specifico, dire che un corpo è pesante equivale a dire che, in assenza di forze opposte, esso cadrà. Altri filosofi, come Mario Calderoni, discepolo e amico fidato di Vailati, erano attratti dal pragmatismo magico, e facevano riferimento a William James. La sprovincializzazione del pensiero italiano era comunque il progetto vailatiano, analogo (per intenzione) e contrario (per contenuti) a quello di Benedetto Croce. Il primo naufragò, il secondo sostituì all’egemonia del positivismo quella del neoidealismo. Forse, azzarda qualcuno dal pubblico del Caffè, perché Vailati non disponeva di una casa editrice, a differenza del filosofo neoidealista fondatore di Laterza. Nel 1907, comunque, Vailati non scrive più sul “Leonardo”, dove ormai, dopo la fase di letterati e artisti e quella di logici e matematici, spadroneggiano maghi e occultisti.
Un’occasione perduta
Non sappiamo se Papini e Prezzolini, vissuti rispettivamente 75 e 100 anni, abbiano mai scoperto che cosa volessero fare nella vita. Certo è che il primo, da ateo degno di anatema, si convertì al cristianesimo e nel 1921 pubblicò la Storia di Cristo. Al contrario Prezzolini nel 1969, quando aveva “anni ottantasei e mesi sette”, scrisse Dio è un rischio, ripubblicato nel 2004 con prefazione di Giulio Andreotti. Giuliano il Sofista è diventato un ateo non rassegnato che nutre ammirazione per la Chiesa. Una figura oggi inflazionata, ma allora piacevolmente rara. Gradevolissima la lettura di quel libro. Prezzolini ha smarrito la turbolenza giovanile, ma ha acquistato un saggio atteggiamento autoironico. Quanto al nostro Giovanni Vailati, purtroppo morì nel 1909 a soli 46 anni e gli mancò il tempo per realizzare il progetto di internazionalizzazione della cultura italiana. Peccato, ci avrebbe fatto un grande piacere.