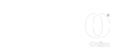“Manzoni sconosciuto. Quello che la scuola non ci ha raccontato”. Questo è il titolo dell’intervento di Fabio Canessa. Ma prendersela con la scuola è come sparare sulla Croce Rossa. Sono stata fortunata: non ho studiato in una scuola dove si leggono I Promessi Sposi a spizzichi e bocconi. Si leggeva integralmente, il romanzo migliore del XIX secolo, modello anche per il XX. Pur fra sbuffi di noia, nell’apprendere che passavano i cavalli dei Lanzichenecchi, e tirando un sospiro di sollievo “quando piacque al cielo”, perché “passò anche Galasso, che fu l’ultimo”, l’abbiamo apprezzato fin dalla prima volta. E non ci sentivamo inadeguati perché troppo giovani, anzi eravamo a nostro agio a quell’età, in quinta Ginnasio. Magari un po’ più maliziosi ma acerbi i maschietti, più partecipi e avide di conoscenza le femminucce, ma adeguatissimi, soprattutto perché quella era la nostra unica educazione sessuale (se si esclude qualche prete insegnante di religione che ci schiudeva mondi proibiti in famiglia). E l’abbiamo amato nonostante docenti non sempre motivanti, nei quali avvertivamo un’indebita beatificazione di Lucia.
Note sì, note no
Ma qui mi permetto di dissentire dall’amico Fabio Canessa, eccellente critico letterario e cinematografico, oltre che insegnante capace di affascinare anche i sassi. Egli sostiene che si dovrebbero leggere i Promessi Sposi senza note, in particolare senza le note di Luigi Russo che scoraggiano e appesantiscono la lettura del testo. La mia edizione del romanzo manzoniano è proprio quella a cura di Luigi Russo, La Nuova Italia, 1961. Non ho mai pensato, pur non amando le note, che lì ve ne fossero troppe o troppo lunghe. Al contrario, il commento di Russo, crociano eretico, faceva da contrappeso laico e liberale a certe romanticherie dolciastre della mia insegnante. Preparatissima, ma frustrata nella vita personale, come scoprii più tardi in uno scambio epistolare con lei, ormai rientrata a Milano dove l’aspettava una vita di dedizione verso la madre malata, e nessun amore terreno per consolarla. Praticamente è questo l’unico punto su cui dissento da Canessa, dato che la sua presentazione, sollecitata da Giovanni Bassi con domande introdotte da letture di critiche letterarie diversificate (Barbero, Bizzocchi e Pierantonio Frare, già relatore ad aprile per gli ex alunni del Racchetti), è risultata come sempre brillante e ancor più del solito “visiva”.
Fermo immagine su alcuni episodi
Non essendoci spezzoni di film da visionare, Fabio metteva a fuoco momenti del libro con un fermo immagine, facendo sì che ai nostri “occhi della mente” si materializzassero, ad esempio, i capponi di Renzo: destinati alla pentola dell’Azzeccagarbugli, anziché cercare di aiutarsi reciprocamente a trovare una via di fuga, si beccano fra loro aggravando la propria situazione. Un’immagine da assaporare magari proiettata accanto all’utopia leopardiana della “social catena” che gli uomini dovrebbero creare per far fronte alla devastante Natura. Ancor più affascinante è l’altro fermo immagine: quello della notte degli imbrogli. Nel momento in cui don Abbondio sbraita dalla finestra di suonare le campane, e Renzo tiene il padrone di casa assediato in una stanza, un osservatore che ignora lo svolgimento dei fatti penserebbe a ruoli capovolti di oppresso e oppressore. Perciò compiangerebbe come vittima quel prete che non fa il proprio dovere, inducendo il povero contadino a un gesto di ribellione pur di ottenere ciò che gli spetta, e viceversa vedrebbe in Renzo, che in realtà subisce il sopruso, un ladro sopraffattore.
Una serata al più bel chiaro di luna
Ma qui di nuovo esce la mia memoria da ex(?)crociana, che inquadra l’episodio nello squarcio poetico: “era il più bel chiaro di luna”. Quali parole usare, se non queste, semplicissime, lontane anni luce da quelle astruserie oggi spacciate per autentica poesia? E per completare l’atmosfera, eccola là, la luna quasi piena, comparire luminosissima fra i rami neri accanto al palco del CremArena. La suggestione è favorita dall’accompagnamento musicale a cura del maestro Enrico Tansini, che trascorre con disinvoltura da Luglio di Riccardo Del Turco a melodie verdiane, da Va’ pensiero all’Amami Alfredo della Traviata, fino al valzer del Gattopardo. Non a caso, perché Giuseppe Verdi, come si sa, dedicò ad Alessandro Manzoni una Messa da requiem.
Fra Cristoforo è morto
Sono stata fortunata, nella più lunga permanenza da insegnante, anche nell’altra scuola dove ho incontrato studenti – molte ragazze e pochi ragazzi – motivati ad imparare. Certo poteva capitare che agli esami qualcuno si perdesse, e alla domanda: “Ei fu, ma chi era poi, questo «ei»?”, preso dal panico rispondesse: “Ehm… al momento mi sfugge”. Ma non era mai accaduto che un candidato, per camuffare l’impreparazione, improvvisasse una sceneggiata come quella raccontata da Canessa: un tipo, anzi, “un bimbino”, così definito in quel toscano che non ha bisogno di risciacquarsi in Arno perché è già candeggiato e smacchiato a dovere, sostiene che il romanzo sia ottimista, perché si chiude con un lieto fine. Il commissario prof. Canessa suggerisce: “Ma fra Cristoforo è morto…”, e quello: “È morto fra Cristoforo? Noooo!”.
Morale della storia
Anche Frare aveva sfidato il pubblico a dire qual è il finale dei Promessi Sposi, perché proprio là dove viene presentato il “sugo di tutta la storia” pare che la scuola odierna sia totalmente assente. Non ci si arriva più. Sulla mia copia del libro leggo una frase di appunti scritta da una me stessa quindicenne: “la morale del Romanzo nella prima parte può essere accettata da tutti, ma la seconda solo da chi crede in Dio”. Già, perché la professoressa credente era attenta anche a chi non lo era, e a chi non aveva ancora capito se lo era oppure no. Ma da quando, mi chiedo, è iniziato lo sfacelo? E pensare che un tempo nutrivo l’illusione di cambiare significato all’aggettivo “scolastico”: da superficiale e approssimativo, aspiravo a farlo diventare sinonimo di appassionante, profondo, irrequieto nella ricerca. Non vorrei recitare la parte del laudator temporis acti, ma ciò che sento della scuola di oggi mi lascia ben più che delusa: mi sprofonda in un luogo oscuro di ombre vaganti senza meta nel non-luogo di un’orrida distopia.
Protagonista il linguaggio
Ma la serata di sabato primo luglio si è invece conclusa con grande gioia e divertimento, grazie alla narrazione di un coltissimo Fabio Canessa, fuoco artificiale di battute ironiche e sentieri poco battuti. Stupefacente l’interpretazione del “quel ramo del lago di Como…” come paesaggio visto dall’alto, il che non può che significare visto da Dio. Smentiti tutti i luoghi comuni, Fabio contrappone all’abituale “il protagonista del romanzo è la provvidenza” una nuova chiave ermeneutica: protagonista è il linguaggio. Quel linguaggio che serve ai potenti per escludere i poveri, che si tratti del latinorum con cui un prete e un avvocato confondono Renzo, o dello spagnolo con cui Ferrer dissimula le proprie intenzioni alla plebe scatenata che vorrebbe il vicario di provvisione in galera, promettendo di portarcelo, si es culpable.
Un autore complesso
Manzoni illuminista o romantico? Illuminista e romantico. E nel Risorgimento moderato o radicale? Forse più radicale, ma fortunatamente capace di pubblicare i suoi scritti senza incorrere in censure e gravi ritorsioni da parte degli Austriaci. Aggiungerei giansenista o gesuita? Giansenista e gesuita. Un credente, comunque, alle prese con il problema mai risolto del cristianesimo: perché mai esiste il dolore? Forse la provvidenza avrà anche un piano universale all’interno del quale tutto il male si giustifica: guerre, peste, malattia, morte di innocenti. Ma questa è filosofia, e la più hegeliana delle filosofie. Di fronte alla vita vera delle persone vere, non possiamo che fare come Lucia: tacere e aver ragione.